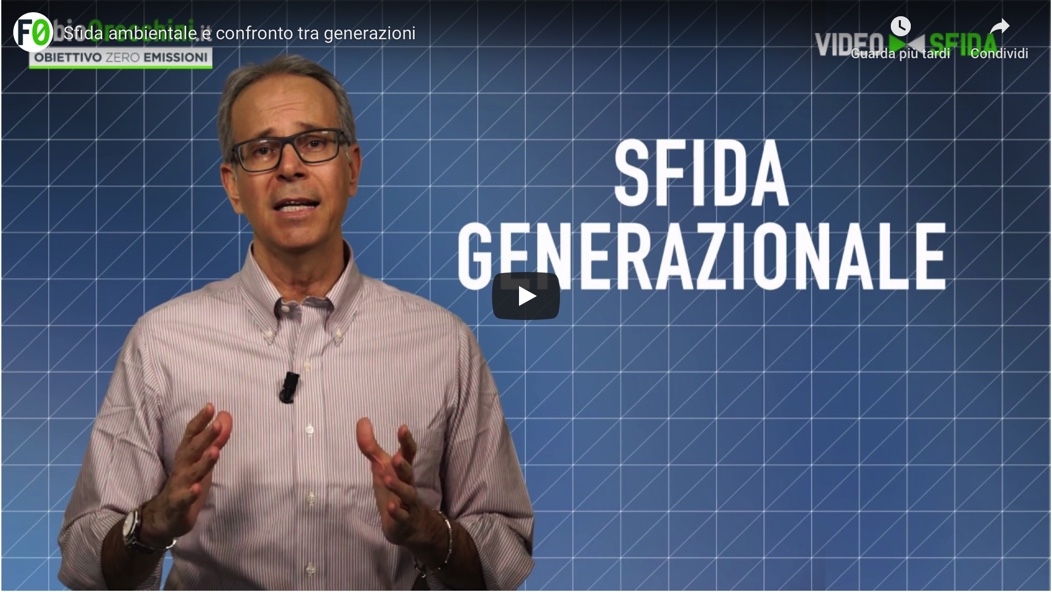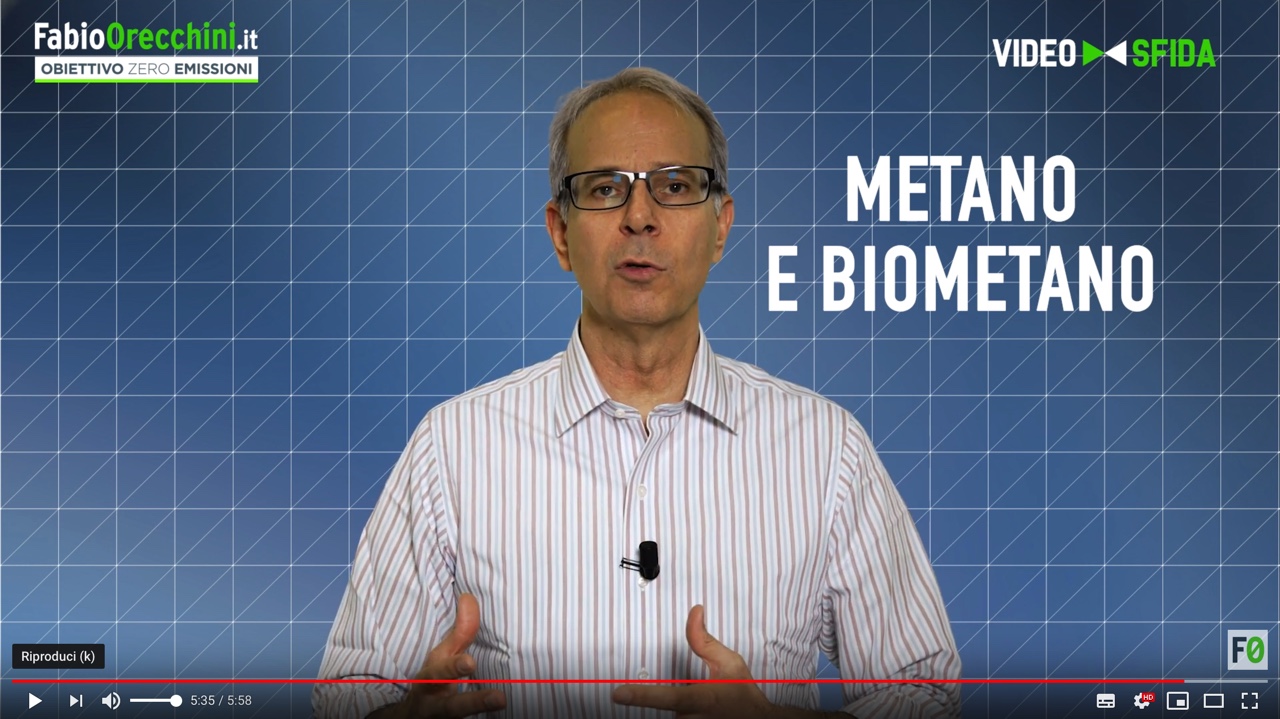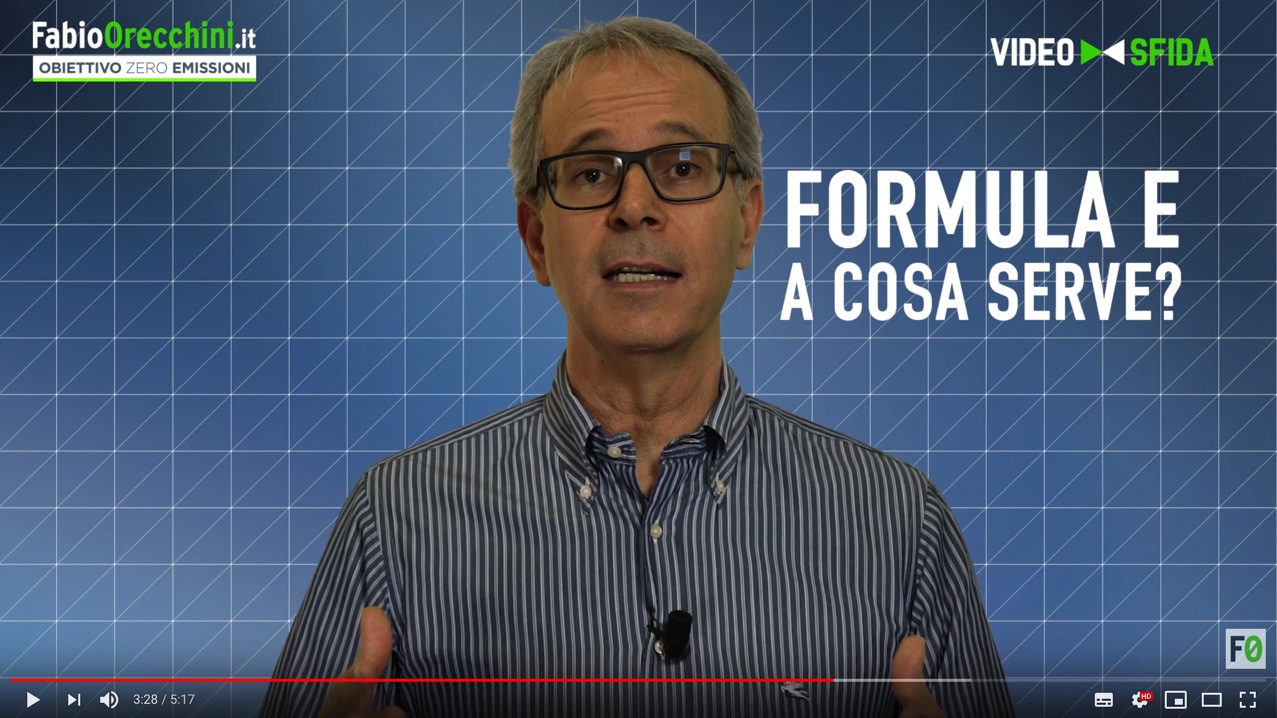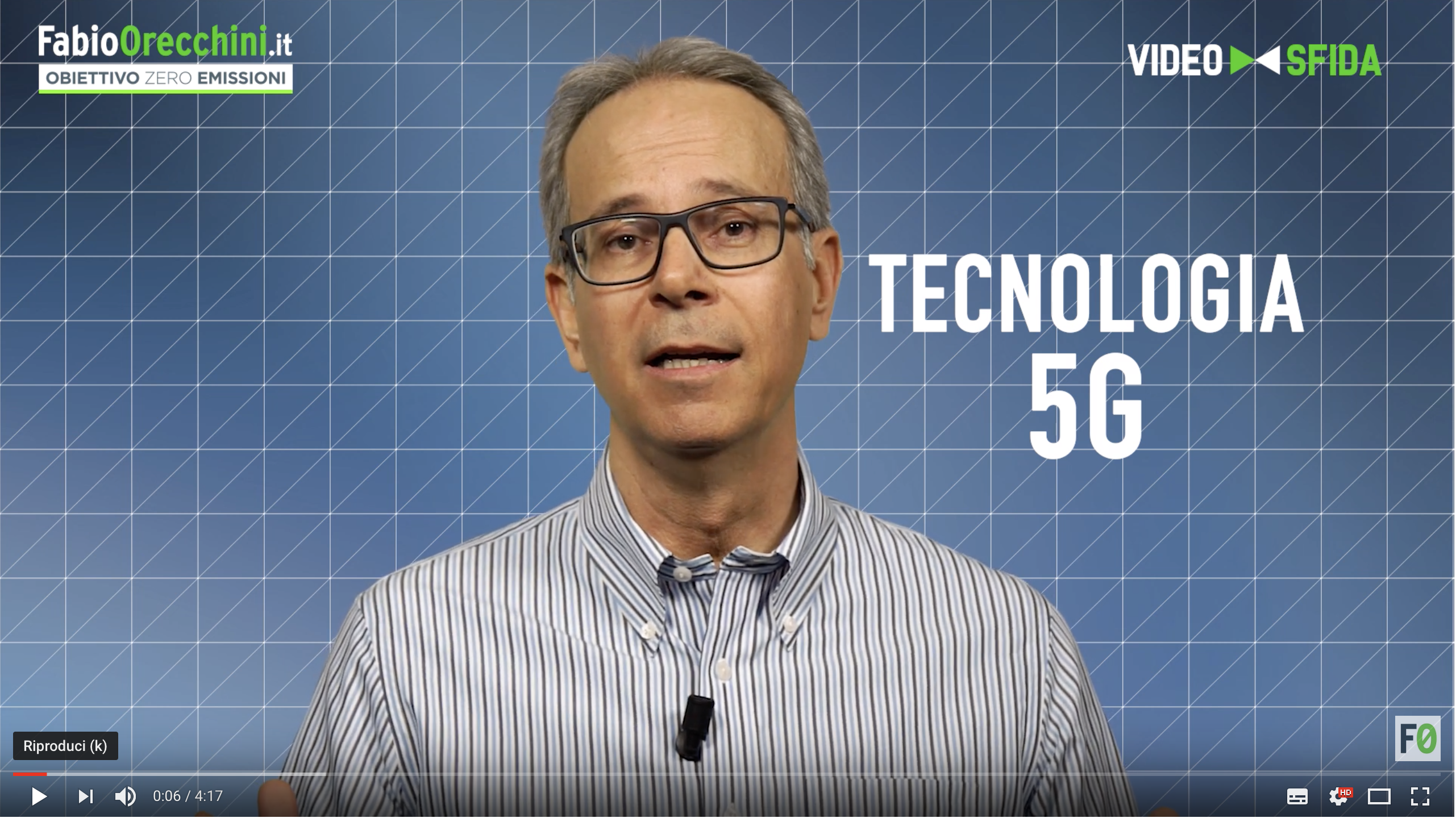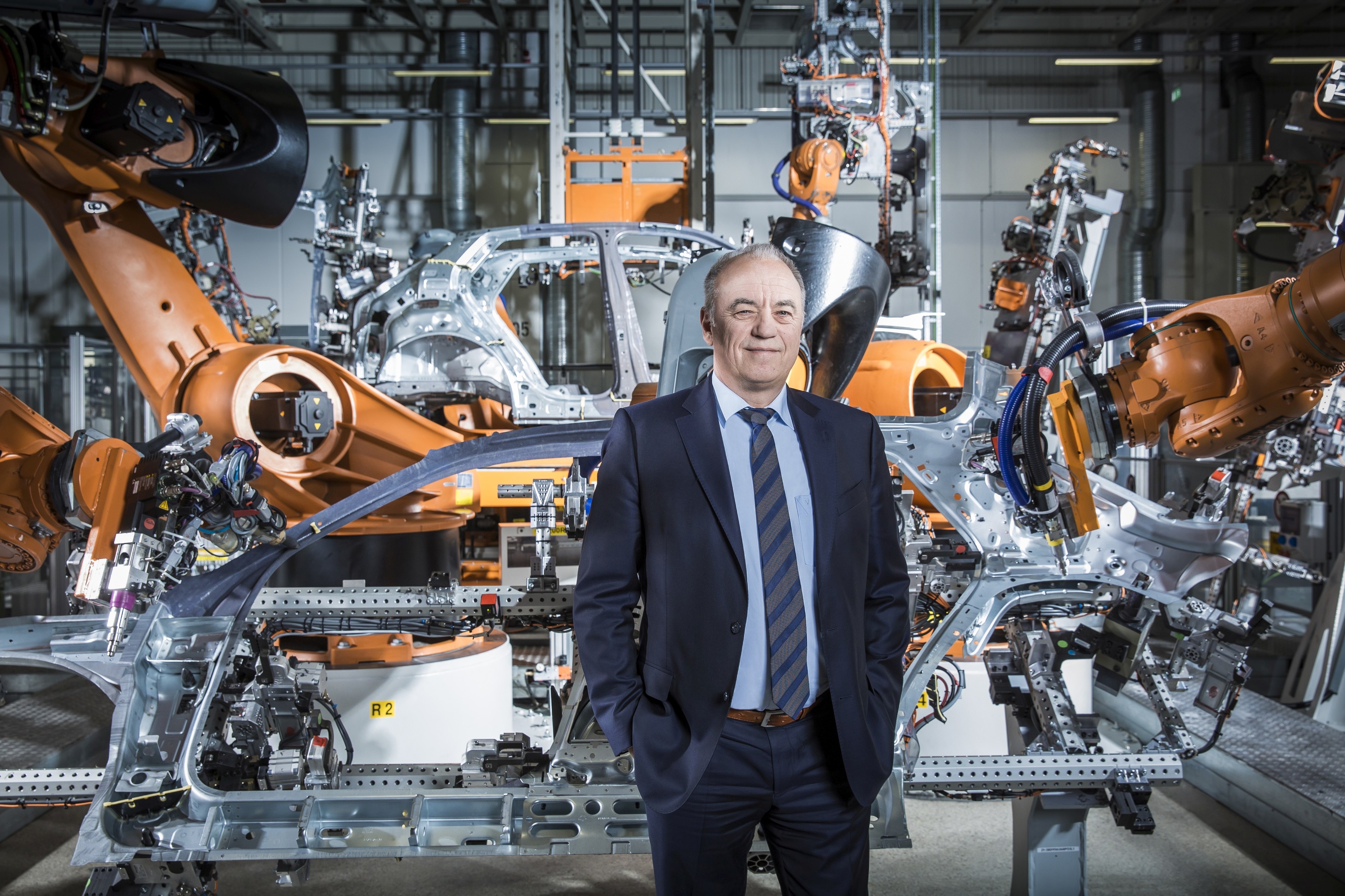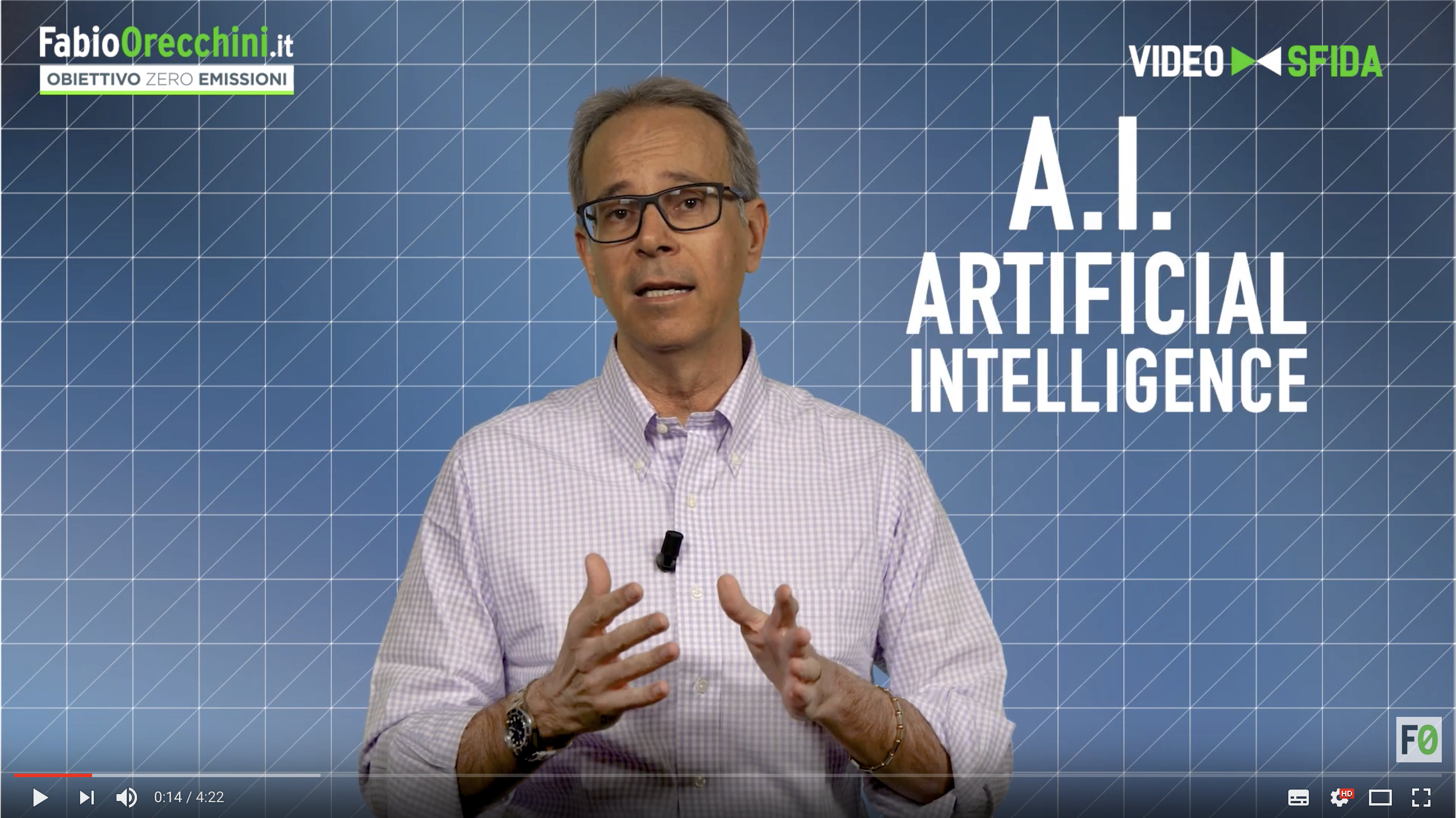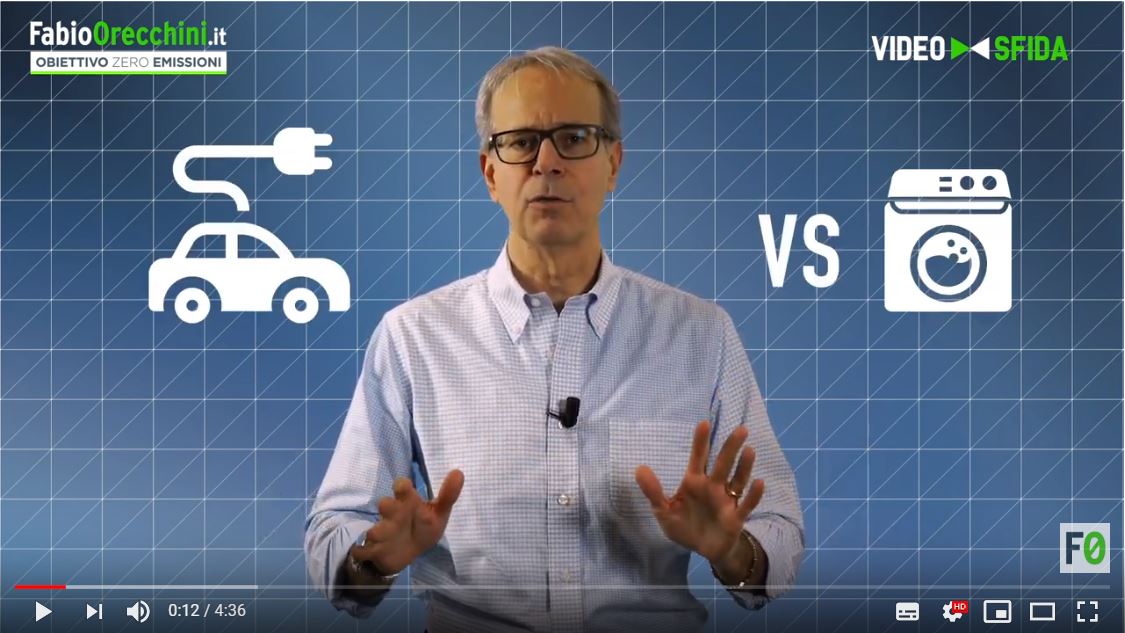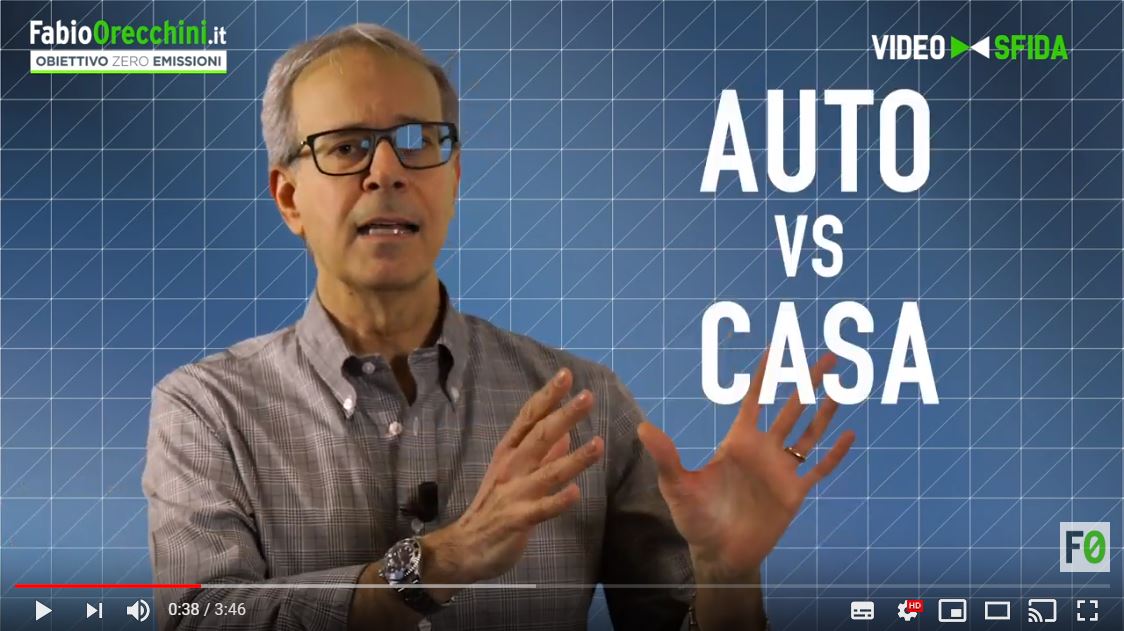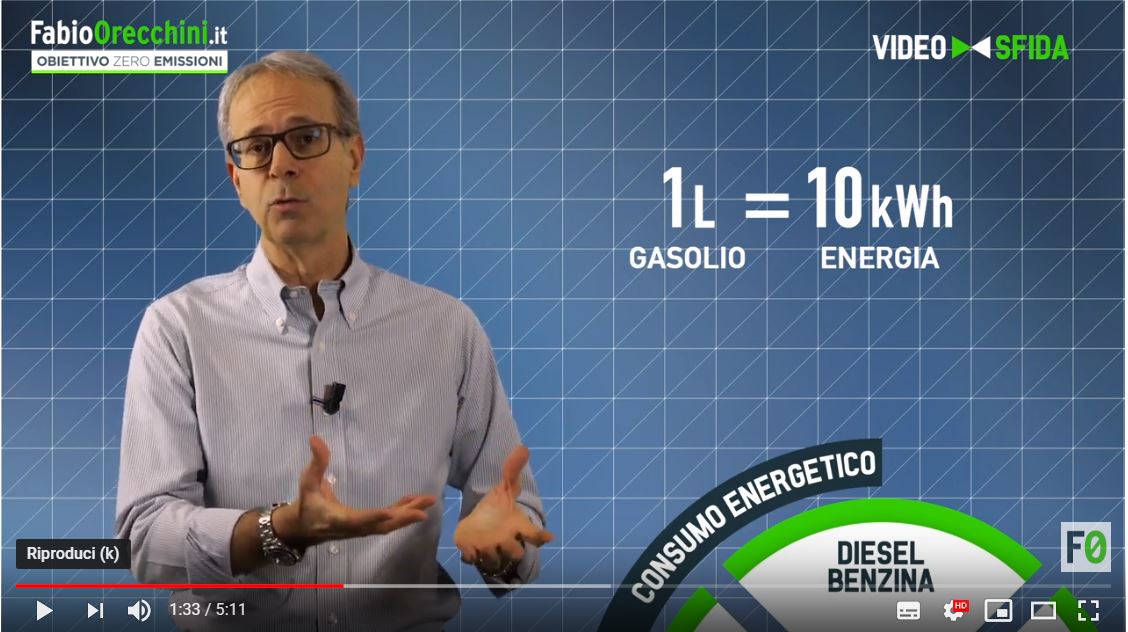Energia, mobilità e ambiente, cinque pilastri per ripartire davvero
Bisogna costruire in modo solido e veloce cinque pilastri nei settori giusti per ripartire. Miopia generale Energia e mobilità sono considerate alla stregua di altri settori da troppi analisti, strateghi e decisori. Tutti affetti da grave miopia, evidentemente. O da incapacità di lettura di situazioni complesse. Industria manifatturiera, turismo, cultura, agricoltura, allevamento, edilizia sono ovviamente …