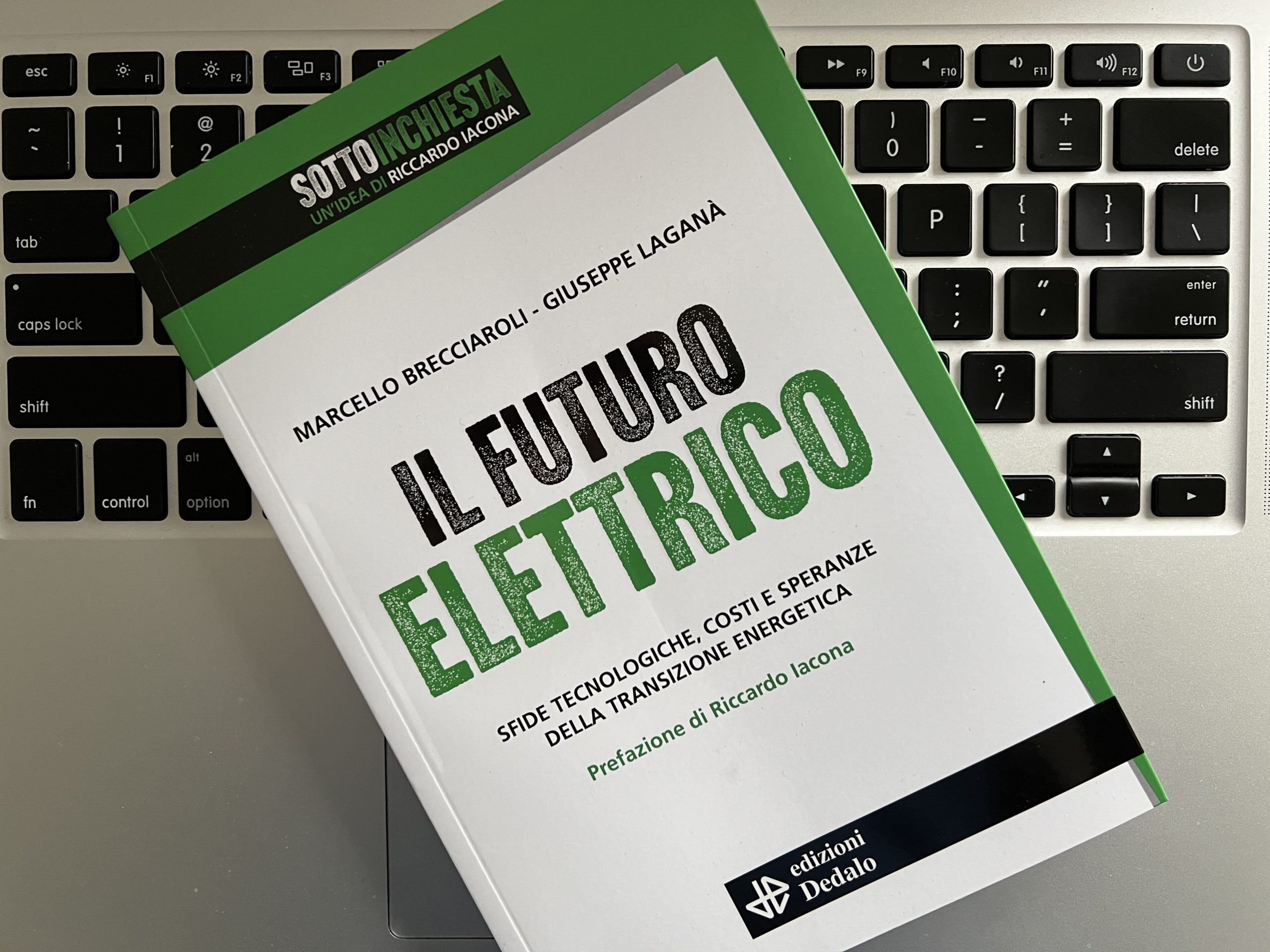Buona Pasqua da Obiettivo Zero Emissioni
Buona Pasqua 2023 da Obiettivo Zero Emissioni. Mentre in Europa continua una guerra che in molti non avrebbero immaginato di dover vivere e ci sono decine (!!) di altri conflitti che continuano a mietere vittime innocenti nel mondo, l’augurio a tutti coloro che si riconoscono in un’umanità alla ricerca di un futuro migliore e anche …